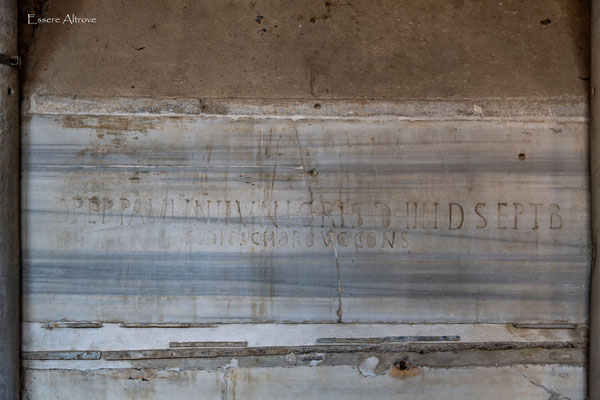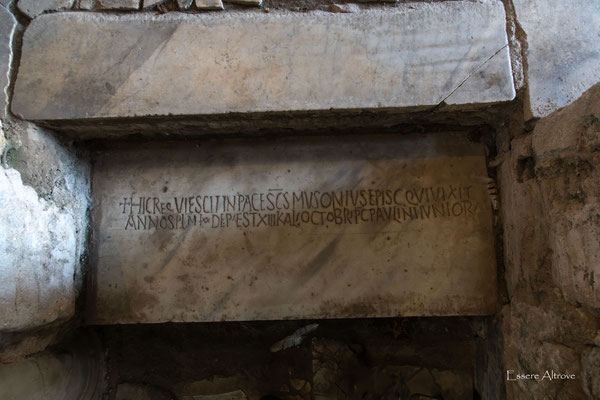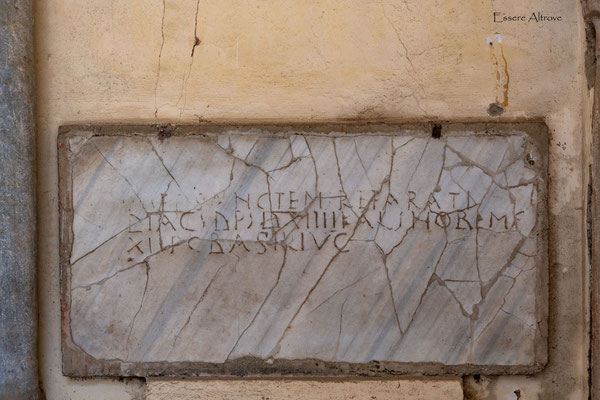- Home
- Chi siamo
- VIAGGI
- EUROPA
- ITALIA Venezia la serenissima
- ITALIA Isole Pelagie
- SPAGNA Toledo
- SPAGNA Madrid
- SPAGNA Barcellona
- SPAGNA Andalusia: tra Europa e Africa
- FRANCIA Normandia e Bretagna
- FRANCIA Oradour sur Glane - Limoges
- FRANCIA La Camargue
- FRANCIA Sara la nera: il pellegrinaggio dei Gitani
- OLANDA Amsterdam - Hoorn
- IRLANDA Dublino - Howth
- INGHILTERRA Londra
- INGHILTERRA Londra inconsueta
- INGHILTERRA Londra - Crossbones Graveyard: le Oche del Vescovo
- INGHILTERRA Windsor - Stonehenge - Bath - Warwick - Stratford upon Avon - Oxford
- SCOZIA I giganti dell'isola di Coll
- SCOZIA I misteri della Cappella di Rosslyn
- REPUBBLICA CECA Praga
- GERMANIA Berlino
- POLONIA Cracovia - Auschwitz Birkenau
- NORVEGIA Bergen
- NORVEGIA Isole Lofoten e Vesteralen
- NORVEGIA Oslo- il museo delle navi vichinghe e il KON-TIKI Museet
- ISOLE SVALBARD
- ISOLE SVALBARD Barentsburg
- ESTONIA
- GRECIA Kerkini, dove osano i pellicani
- AFRICA E MEDIORIENTE
- AMERICA DEL NORD
- ASIA
- OCEANIA
- RUBRICHE DI VIAGGIO
- COSA E' IL CICLOTURISMO 7 consigli per praticarlo
- DIECI PRATICI CONSIGLI DI VIAGGIO
- FOTOGRAFIA DI VIAGGIO: il reportage
- DIS/AVVENTURE DI VIAGGIO
- VIAGGIARE E' PERICOLOSO?
- L'ASSICURAZIONE DI VIAGGIO
- SMARRIMENTO DEL PASSAPORTO IN VIAGGIO
- VOLARE La tutela del passeggero nell'Unione Europea
- LOST AND FOUND bagaglio smarrito o danneggiato: che fare
- VIAGGI E DISABILITA'
- VIAGGIARE: ROBA DA RICCHI?
- IL VIAGGIO COME NECESSITA': la storia di Samir
- PROBLEMATICHE GIURIDICHE DELL' ATTIVITA' SUBACQUEA IN ITALIA
- EUROPA
- URBAN EXPLORATION
- VARIE
- URBEX AL FEMMINILE: ESPLORATRICI SI RACCONTANO
- ANTICHE DIMORE
- VILLA DE VECCHI, LA CASA ROSSA
- IL CASTELLO DI PRALBOINO
- LA CASCINA ALLUVIONI BRANCERE
- LA VILLA CHE HA ATTRAVERSATO IL TEMPO
- LA VILLA DEL RABBINO
- VILLA C. una perla di rara bellezza
- LA VILLA DEL GEOLOGO
- LA VILLA DELLA TERZA MADRE: MATER LACRIMARUM
- VILLA MOGLIA
- VILLA MINETTA
- IL PALAZZO D'ORO: la mano del diavolo
- IL PALAZZO DELL'ALCHIMISTA
- LA CASA DEL SOLDATO O DEL LETTO VERDE
- LA VILLA DELLA MADONNINA LUCCICANTE
- LA VILLA DEL BAMBINO VESTITO DI BIANCO
- LA VILLA DEL CONTE
- LA CASCINA DELLA FIAT 1100
- LA CASCINA DEL MARCHESE
- LA VILLA SULLA COLLINA
- LA VILLA DELLA PANTERA ROSA
- LA CASA DELL'ALLENATORE
- LA VILLA DELL'ARTISTA
- VILLA POPPINS
- LA VILLA DEI GUELFI BIANCHI
- LA VILLA DEL MATEMATICO
- LA VILLA DEI PAPPAGALLI
- LA VILLA DEL GEOGRAFO
- LA VILLA DELLA DEA
- LA VILLA DEGLI SPECCHI GEMELLI
- VILLA MIRABELLA
- VILLA SANT'OTTAVIA: LA STREGA DI POMARANCE
- VILLA MADONNA G., LA BELLEZZA FERITA
- LA VILLA DELLA RESISTENZA
- LA VILLA DEI LEVRIERI
- LA VILLA DEL SEQUESTRO
- LA VILLA DELLA BARCA A VELA
- LA CASA DELLA BAMBOLA
- IL PALAZZO DEL CARDINALE
- LA VILLA DEL MISTERO
- ANNA VITA, LA CASA DELL'ATTRICE SCULTRICE
- LA CASA DEL MONARCHICO
- IL CASALE MARCHESANI
- LA CASA NEL BOSCO the Witch's house
- LA VILLA DELLA POSTINA
- LA VILLA DELLE ANIME INQUIETE
- VILLA ADDAMS
- LA VILLA DEL COMANDANTE
- LA VILLA DEL PRINCIPE ARCHEOLOGO
- LA VILLA DELLE TRECENTO STATUE
- LA CASA DEI SETTE OMICIDI
- LA VILLA DEI DRAGHI
- LA VILLA DEGLI SPETTRI
- LA VILLA DEVASTATA DAI NAZISTI
- PALAZZO ANGKOR
- EX STRUTTURE MILITARI
- EX STRUTTURE RELIGIOSE: conventi, chiese, cimiteri
- VILLA VALBISSERA E LA CHIESA DI SANTA EUROSIA
- IL CIMITERO ABBANDONATO IN CIMA ALLA COLLINA
- IL CIMITERO ABBANDONATO DELLA DAROLA
- LA CHIESA DELLA MADONNA DELLE VIGNE: LO SPARTITO DEL DIAVOLO
- IL SANTUARIO DELLE ELEMOSINE
- EX CHIESA DI RIGOSA DI ROCCABIANCA
- IL CONVENTO DELLA CHIESA BLU
- L'ORATORIO DELLE STATUE CHE PIANGONO
- LA CHIESA CHE SFIDA LE NUVOLE
- LA CHIESA DELLA CROCE BLU
- LA CHIESA DELLA TROTTOLA
- IL PICCOLO CIMITERO NEL BOSCO
- LA CHIESA DEL CANE DELL'INFERNO
- IL CONVENTO DELLE CONFESSIONI
- IL CONVENTO DELLA MORTE
- CAVALIERI O SANTI?
- IL CONVENTO DELLA CHIESA BIANCA
- IL CONVENTO DI SAN BERNARDINO
- LA CHIESA NEL BOSCO E LA MADONNA DELLA QUERCIA
- LA CHIESA DEL LAGO
- LA CHIESA DEI MISTERI
- IL CONVENTO CHE FU CASERMA, OSPEDALE E CARCERE
- L'EREMO DELLE OSSA
- IL MONASTERO DELL'ULTIMO VIAGGIO
- IL CONVENTO DELLA MADONNA "LATTANTE"
- IL MONASTERO DI PIETRA
- LA CAPPELLA AZZURRA
- IL MONASTERO DELLA SORGENTE DELLA VITA
- EX CONVENTO DEI FRATI CAPPUCCINI DI AVERSA
- IL CONVENTO DELLE OSSA
- IL CONVENTO DELLA FONTE MIRACOLOSA
- LA CHIESA DEL TESCHIO
- IL CONVENTO DEI CAPPUCCINI DI MONTESARCHIO
- IL SIGILLO DEL TEMPO
- CONVENTO DELLA SS. TRINITA' DELLE MONACHE
- MAMMA LI TURCHI: IL CONVENTO DELLA LEGGENDA
- LA CHIESA DELLA MADONNA DI GRAZZANO
- LA CHIESA DEL MONTICELLO
- CIMITERO ABBANDONATO DI F.
- IL CIMITERO DEI MORTICELLI DI BENEVENTO
- LA CAPPELLA DI SAN GIORGIO
- LA CHIESA SULLA COLLINA DEI FALCONI
- ORA ET LABORA: IL MONASTERO CHE FU OSPEDALE DEI POVERI
- LA CHIESA DEI BAULI
- LA CHIESA DEI SOSPIRI
- LA CHIESA DEGLI ANGELI CON LA CROCE
- LA CHIESA DEGLI ANGELI CADUTI
- LA CHIESA DELLE TRE CAPUZZELLE
- SILENT HILL
- SICIGNANO DEGLI ALBURNI Il convento del monaco indemoniato
- PETINA Il Monastero di Sant'Onofrio
- IL CONVENTO DI SAN FRANCESCO D'ASSISI
- VEICOLI: treni, aerei, automobili
- INSTALLAZIONI INDUSTRIALI
- LUOGHI DI DIVERTIMENTO E SPORT: cinema, teatri, parchi giochi, discoteche
- MAGIC MOVIE PARK, apocalisse urbana
- IL FANTASMA DELL'OPERA
- CINE TEATRO ENAL
- CINEMA TEATRO RENO
- JURASSIC POOL: lo stadio del nuoto abbandonato
- EX DISCOTECA EXCALIBUR: il castello del divertimento
- DISCO BOWLING ABBANDONATO Echi di risate nel buio
- L'ACQUAPARK ABBANDONATO
- JURASSIC URBEX
- TENTAZIONE ROSSA
- CINEMA TEATRO MASTROGIACOMO: la capsula del tempo
- CINEMA TEATRO CENTRONE
- MIRAGICA La luna è andata via
- ALBERGHI E COMPLESSI TERMALI
- STRUTTURE SANITARIE: sanatori, manicomi, ospedali
- EX SANATORIO "GUIDO SALVINI" DI GARBAGNATE
- EX PREVENTORIO "ROCCO CHIAPPONI"
- EX OSPEDALE SANATORIO
- FANTASMI IN CORSIA
- IL COMPLESSO MEDICO LE C.
- L'OSPEDALE DELL'OPERA PIA MILANI ROSSI
- L'OSPEDALE DI BENEFICENZA
- EX MANICOMIO DI RACCONIGI: un viaggio nella "Fabbrica delle idee"
- EX MANICOMIO DI VOGHERA
- EX MANICOMIO DI COLORNO
- EX MANICOMIO SAN LAZZARO DI REGGIO EMILIA
- EX MANICOMIO PEDIATRICO DI AGUSCELLO
- EX MANICOMIO DI MAGGIANO
- EX MANICOMIO DI VOLTERRA, L'INFERNO SULLA COLLINA
- EX MANICOMIO DI PISTOIA Ville Sbertoli
- EX MANICOMIO DI COLLEMAGGIO
- MANICOMIO DI AVERSA ex Ospedale Psichiatrico della "Maddalena"
- EX MANICOMIO DI NAPOLI LEONARDO BIANCHI: IL LABIRINTO DELLA RAGIONE
- EX OPG NAPOLI Un inferno chiamato manicomio giudiziario
- EX MANICOMIO MATERDOMINI DI NOCERA
- EX MANICOMIO INFANTILE il palazzo dei bambini dimenticati
- ISTITUTI TECNICO- DIDATTICI E SCUOLE
- ORFANATROFI, COLLEGI E COLONIE
- EX CARCERI
- FABBRICHE
- ANTICA FILANDA
- EX COTONIFICIO: LA PRYPIAT DEL TESSILE
- L'EX AERONAUTICA CAPRONI DI PREDAPPIO
- EX STABILIMENTO DELLE ACQUE MINERALI
- EX ZUCCHERIFICIO SAZA
- UN'ANTICA CARTIERA
- UN MOSHAV IN CAMPANIA
- EX OLIVETTI il futuro divenuto passato
- EX STABILIMENTI CORRADINI
- JURASSIC TRAVEL
- EX CONSORZIO AGRARIO
- CRA - CAT Centro ricerca colture alternative al tabacco
- GLI EX TABACCHIFICI DELLA PIANA DEL SELE
- IL MULINO DEI PIPISTRELLI
- GHOST TOWN
- PYRAMIDEN,LA CITTA' MINERARIA ABBANDONATA
- IL BORGO DI VETTIGNE' E IL CONVENTO DI SAN GIORGIO
- FARAONE ANTICO
- REOPASTO
- ROCCHETTA ALTA
- CROCE, IL RESPIRO DELLA MONTAGNA
- ROSCIGNO VECCHIA
- APICE VECCHIO
- TOCCO CAUDIO
- CASTELPOTO
- PADULI
- TRAPPETO, UNO SGUARDO SUL PASSATO
- MELITO IRPINO
- ROMAGNANO AL MONTE
- SENERCHIA
- AQUILONIA VECCHIA, L'ANTICA CARBONARA
- CONZA DELLA CAMPANIA
- CRACO
- ALIANELLO VECCHIO
- CAVALLERIZZO, IL PAESE SCIVOLATO VIA
- AMENDOLEA
- PAPAGLIONTI VECCHIA E LA GROTTA TRISULINA
- NAPOLI
- HANNO SCRITTO SU NAPOLI
- NAPOLI GRANDE SIGNORA Augusto De Luca
- GIANCARLO PICCOLO, IL MIO INCONTRO COL MALE
- LA CAPPELLA DI SANTA VALENTINA
- LA CHIESA DI SANTA MARIA DEL PARTO E IL DIAVOLO DI MERGELLINA
- CONVENTO DELLA SS. TRINITA' DELLE MONACHE
- L'ASCENSORE FANTASMA DEL MONTE ECHIA
- LA CHIESA DELL'IMMACOLATELLA
- REGGIA DI CAPODIMONTE tricentenario della nascita di Carlo di Borbone
- NAPOLI INCONTRA IL MONDO edizione 2017
- EX ASILO FILANGIERI Festibal Viva o Senegal
- LA CASINA SUL FUSARO
- L'ARTE INCONTRA LA STORIA La bottega del maestro Aldo Vucai
- LA PROCESSIONE DEI FRATI MORTI
- LA CHIESA DELLA SACRA FAMIGLIA DEI CINESI
- LA CHIESA DI SANT'ANNA DEI LOMBARDI E LA CRIPTA DEGLI ABATI
- L'OSPEDALE DELLE BAMBOLE
- LA CHIESA CHE CAMBIÓ NOME TRE VOLTE
- AUGUSTISSIMA COMPAGNIA DELLA DISCIPLINA DELLA SANTA CROCE
- LA REAL CASA DELL'ANNUNZIATA DI NAPOLI
- L'ARCHIVIO STORICO DEL BANCO DI NAPOLI
- SANTA MARIA LA NOVA il conte Dracula è sepolto a Napoli
- GIOVANBATTISTA DELLA PORTA E L'ACCADEMIA DEI SEGRETI
- MUSEO DELLE ARTI TIPOGRAFICHE
- IL MONASTERO DELLE "TRENTATRE"
- I MUSEI FEDERICIANI Antropologia - Fisica - Mineralogia - Paleontologia - Zoologia - Anatomia
- LO STABILIMENTO BOTANICO CALABRESE
- IL GIARDINO DI BABUK
- SAN GIOVANNI A CARBONARA
- SS. MARIA DELLA MISERICORDIA AI VERGINI
- IL MUSEO DI JAGO
- L'IPOGEO DEI CRISTALLINI
- CHIESA DI SAN DOMENICO MAGGIORE La Cripta dei Carafa di Roccella
- JURASSIC NAPOLI:IL VALLONE SAN ROCCO
- IL MUSEO DEL SOTTOSUOLO
- NEL BUIO, ECHI DI GUERRA
- LA NAVE DEGLI SCUGNIZZI
- IL CIMITERO DELLE FONTANELLE Il culto delle anime "pezzentelle"
- IL CIMITERO DELLE 366 FOSSE
- LA CHIESA DEL TESCHIO CON LE ORECCHIE: SANTA LUCIELLA, STORIA DI UNA RESURREZIONE
- LA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI
- IL PARCO DEI MURALES
- JORIT AGOCH un Caravaggio con la bomboletta spray
- LA GENESI DEI GENESIS
- LA CRYPTA NEAPOLITANA E VIRGILIO MAGO
- ENIGMI NAPOLETANI Negligit ima
- ANTICHE DIMORE NAPOLETANE
- IL MISTERO DELLA FACCIATA DEL "GESU' NUOVO"
- BIANCA Il fantasma di Via Tribunali
- SAN GIOVANNI A MARE religiosità popolare e antichi culti pagani - Lucrezia D'Alagno, la favorita del Re
- TRACCE DI TRADIZIONI CELTICHE NELLA CULTURA NAPOLETANA Le anime erranti
- CARO MASSIMO
- VENIAMO NOI CON QUESTA NOSTRA ADDIRVI: c'erano una volta i Fratelli Caponi
- MUSEO GAETANO FILANGIERI
- CARLO ROSSI FILANGIERI, L'ARCHEOLOGO GENTILUOMO
- VILLA ROSSI FILANGIERI A TORRE ANNUNZIATA
- ANNA E RODOLPHE una storia napoletana
- LA BIBLIOTECA CIRCOLANTE DI LARGO S.ORSOLA A CHIAIA
- CARLO ROSSI FILANGIERI JR Remiamo insieme per la vita
- ITINERARI NAPOLETANI:PIEDIGROTTA - MERGELLINA
- BORGHI E STORIE D'ITALIA
- TRIORA Il lamento delle Streghe
- SAN GALGANO: la spada nella roccia
- L'ABBAZIA CAMALDOLESE DI VOLTERRA
- ROCCA CALASCIO dove i lupi proteggono i falchi
- I SERPARI DI COCULLO
- IL CARNEVALE DELLE MASCHERE ZOOMORFE DI ISERNIA
- GL' CIERV, LA LEGGENDA DELL'UOMO CERVO
- LA PROCESSIONE DEL CRISTO MORTO MORTO DI ORTE
- FUMONE, IL CASTELLO DEGLI SPETTRI
- GAETA la signora del mare
- VALOGNO i colori del grigio
- PORTRAIT D'ARTISTE: ALFREDO TROISE
- MONTI TREBULANI Una notte sull'Eremo di San salvatore
- MONDRAGONE:i resti dell'antico villaggio del Cenito
- IL PONTE SOSPESO DEI BORBONE
- SAN LEUCIO il vecchio Casino di caccia dei Borbone
- REGGIA DI CASERTA: IL PARCO ED IL GIARDINO INGLESE
- CAVALIERI E DEMONI: viaggio nel ventre della Casoria antica
- PRATA SANNITA, LA VECCHIA CARTIERA SUL FIUME LETE
- RUPECANINA, LA ROCCAFORTE DEI NORMANNI
- SAN LUPO, IL PAESE DELLE JANARE
- LA LEGGENDA DELLE STREGHE DI BENEVENTO
- BENEVENTO Il Cimitero dei "morticelli"
- SANT'AGATA DE' GOTI
- BONITO tra arte, storia e mistero
- LA CANDELORA E LA IUTA DEI FEMMINIELLI A MONTEVERGINE
- IL PONTE PRINCIPE DI LAPÌO
- LAPIO E IL CASTELLO DEI FILANGIERI
- I RITI SETTENNALI DI PENITENZA DI GUARDIA SANFRAMONDI
- L'O.P.G. DI AVERSA
- MONTELLA il convento di Santa Maria della neve
- LE BASILICHE PALEOCRISTIANE DI CIMITILE
- SOMMA VESUVIANA l'archeologia venuta da lontano: gli scavi della villa di Augusto
- SOMMA VESUVIANA Il complesso monastico dei Frati Minori di Santa Maria del Pozzo
- CICCIANO Tammorre e Falò: la notte di Sant'Antonio
- IL CARNEVALE PALMESE Edizioni 2020 - 2023
- CASTELLAMMARE - Il cinema albergo MONTIL
- GOLETO, L'ABBAZIA DEL MISTERO
- ANTICA FAGGETA DEL MONTE FAITO
- SORRENTO La processione nera del venerdì santo
- IL CARNEVALE DI MAIORI
- AMALFI la valle delle Ferriere
- SENERCHIA Oasi WWF Valle della Caccia
- CASTELNUOVO DI CONZA Il fuoco della rinascita
- ISCHIA il Castello aragonese
- PROCIDA il carcere Borbonico
- COMPSA Il Parco archeologico di Conza della Campania
- EBOLI La "Strangulatora"
- CAMPAGNA venerabili confraternite monte dei morti della beata vergine del Carmelo e SS. Nome di Dio
- PRAIA il Santuario della Madonna della Grotta
- VATTIENTI DI NOCERA
- MONTI DAUNI, UN ANGOLO DI PROVENZA IN PUGLIA
- LA MURGA DEGLI ESPANTAPAJAROS
- LA DESOLATA DI CANOSA DI PUGLIA
- ISOLE PELAGIE Lampedusa e Linosa
- GALLERIE FOTOGRAFICHE
- COLOURS OF INDIA
- ARTICA
- PELLICANI
- MEGATTERE
- KINGDOM OF TONGA
- PARIGI, la Ville Lumiere
- LA CAMARGUE
- BULGARIA Sofia
- SCOZIA
- FIRE albe e tramonti nel mondo
- CASTELLI
- EX SANATORIO GARBAGNATE
- ANTICHE DIMORE NAPOLETANE
- IN VOLO SUI TEMPLI festival delle mongolfiere di Paestum
- AMALFITANA
- ISCHIA
- ISOLE PELAGIE
- SANT'AGATA DE' GOTI
- CASORIA TRA STORIA, FEDE ED ABBANDONO
- I BATTENTI DI GUARDIA SANFRAMONDI
- LINK UTILI
- FRIENDS
- VIDEO
- LIBRI
- DICONO DI NOI
- Contatti
LE BASILICHE PALEOCRISTIANE DI CIMITILE

Il complesso di Cimitile è uno di quei luoghi che, per fortuna o sfortuna (a secondo da che punto di vista si consideri la faccenda), non ha conosciuto ancora il turismo di massa al pari di quelli che fanno parte del circuito più classico ed ufficiale (Pompei, Ercolano, Paestum etc.). Se consideriamo il patrimonio storico artistico dal punto di vista commerciale, non è un bene: il business culturale porta visibilità e denaro, dunque risorse per la gestione e la conservazione dei manufatti. Se, tuttavia, non consideriamo questo genere di cose dal punto di vista della resa economica, ma come qualcosa di importante per l’umanità intera, allora forse è un bene: rimane inquadrato in un’ottica puramente culturale, di salvaguardia e di studio e ne guadagna in autenticità.
Sembra quasi che questo luogo voglia nascondersi, rifuggire la notorietà confondendosi con l’abitato odierno fatto di mille stradine che si intersecano. Solo da qualche anno il santuario sta acquistando maggiore popolarità grazie a spettacoli ed eventi come il “Premio Cimitile”, rassegna letteraria nazionale, la cui premiazione si svolge all’interno del complesso delle Basiliche. Tra le sezioni del premio è presente “Saggistica e Archeologia e cultura artistica in età Paleocristiana e Altomedievale”.
Il complesso si trova dentro l’abitato di Cimitile che lo ha ormai inglobato. In origine si accedeva da cd “Arco santo, mentre oggi l’ingresso è da via Madonnella. Sviluppatosi su un preesistente Coemeterium romano, l’area annovera sette edifici sacri di età paleocristiana e medievale, dedicati ai santi Felice, Calionio, Stefano, Tommaso e Giovanni, ai Ss. Martiri e alla Madonna degli Angeli. Un complesso d’arte romanica, bizantina e barbarica che rappresenta senza dubbio alcuno uno dei più importanti lasciti dell’Occidente cristianizzato. Cimitile non manca di rappresentare anche un enigma, ancora fonte di discussioni e di studio, ed anche in questo risiede il suo fascino, per le rappresentazioni iconografiche ormai in dissonanza con quello che è stato lo sviluppo del credo cristiano. Questo luogo rivela la decostruzione del cristianesimo delle origini attraverso secoli di violente lotte interne alla chiesa a favore di una narrazione che si è spinta lontano da quelle medesime origini.
Tutto ruota attorno alla figura di Felice, uomo forte, frugale e di granitica fede. Figlio di un uomo di origini orientali, divenne prete e proprio durante le persecuzioni rimase a salvaguardia della chiesa locale, laddove il Vescovo Massimo era fuggito sulle montagne. Molte volte imprigionato, Felice sopravvisse alle persecuzioni alimentando in proposito svariate leggende. Alla morte del Vescovo Massimo, Felice rinunciò al porporato e trascorse il resto dei suoi giorni in preghiera e povertà. Felice morì in un anno non conosciuto e fu seppellito nel coemeterium nolano; fu proprio da quel momento che la necropoli pagana si trasformò in un santuario cristiano. La venerazione per la figura di Felice, divenuto San Felice, portò alla costruzione di nuove e numerose tombe cristiane. Nel gennaio 313 Costantino imperatore d'Occidente e Licinio imperatore d'Oriente a Milano firmano un editto col quale riconobbero il cristianesimo religio licita (Editto di Milano). Il cristianesimo esce dalla clandestinità ed il sepolcro di San Felice divenne meta ininterrotta di pellegrinaggi. L'attività edilizia che si sviluppò attorno al sepolcro di San Felice è, quindi, intimamente connessa con la devozione per il santo. Tutti desideravano essere sepolti vicino a lui ed era necessario trovare sempre nuovi spazi. Si pensi che questo sito è stato usato per le sepolture fino al 1838.
Fu, tuttavia, Meropio Ponzio Paolino, passato alla storia come Paolino di Nola, colui che più contribuì a glorificare e fare conoscere la figura di San Felice. Divenuto governatore della Campania, si stabilì definitivamente insieme alla moglie Terasia nei pressi del santuario ed impiegò il suo patrimonio per esso. Fece sistemare gli edifici esistenti, lastricare la strada che da Nola porta al santuario, costruire una nuova basilica, la basilica nova, e alloggi per i poveri. Divenne vescovo di Nola nel 409, morì nel 431 e fu sepolto nel santuario cui aveva dedicato la propria vita e le proprie ricchezze. Nel VI secolo il santuario fu danneggiato da una violenta alluvione, ma ben presto si tornò a costruire. Tra VI e VII venne aggiunta una nuova chiesa dedicata all'apostolo Tommaso, mentre la basilica nova e S. Stefano furono restaurate e impiegate a scopo funerario. Tra VIII e IX secolo i Longobardi di Benevento trafugarono il corpo di S. Paolino e alcune reliquie di S. Felice, ma, ciò nonostante, il santuario mantenne intatta la sua importanza.
Nell’VIII secolo la basilica nova crollò e quel che rimase fu trasformata nella chiesa di S. Giovanni. Infine, nel IX secolo furono realizzati interventi dal vescovo Leone III, nella basilica di S. Felice e nelle cappelle di S. Calionio e dei Ss. Martiri.
La basilica di S. Felice cominciò ad essere usata come parrocchia di Cimitile ed era retta da un funzionario assistito da sette sacerdoti, detti “confrati'”. Fino al 1675 si mantenne l'usanza di recarsi tre volte l'anno in processione alla basilica di S. Felice.
L'eruzione del Vesuvio del 1631 danneggiò alcuni edifici. Al termine di una lunga controversia legale, nel 1675 il santuario, che dalla fine del XV secolo era sotto il controllo del capitolo di Nola, ritrovò la sua autonomia.
Tra la metà del ‘700 e i primi decenni dell’800 le locali confraternite vi fecero cospicui interventi di ristrutturazione. Tuttavia, già nell’800 il santuario versava in stato di decadenza ed abbandono denunciato spesso dai viaggiatori, soprattutto stranieri, che visitavano il complesso. Solo verso la fine dell’Ottocento si mise mano a qualche intervento. Dagli anni Trenta ai Sessanta del Novecento furono a più riprese condotte ricerche e scavi archeologici, nel tentativo di recuperare l’originario assetto del complesso, con risultati molto controversi. A lungo chiuso, il santuario è stato finalmente riaperto alle visite dal comune che lo ha in gestione dagli anni Ottanta.
Questa in estrema sintesi l’articolata storia del complesso attraverso i secoli. Un luogo antico che ha visto il tramonto dell’epoca classica e la fine dell’Impero Romano, ha attraversato il medioevo, l’età moderna per arrivare fino a noi con immutato fascino.
Questo luogo non ha attirato solo fedeli, archeologi e storici dell’arte, ma anche studiosi ed appassionati di discipline esoteriche. I suoi segreti resi ancora più oscuri dal tempo risiedono soprattutto nell’iconografia e nella simbologia presente. Tra tutti spicca l’affresco della Maddalena presente nella Basilica dei SS Martiri. La Maddalena dipinta qui porta una corona ed ha un aspetto regale; si pensa che questa rappresentazione sia legata ai tanti racconti evangelici, dichiarati poi dalla chiesa apocrifi in favore dei soli quattro vangeli ammessi (canonici), che la descrivono non come una prostituta peccatrice ma come una figura importante nella cerchia di Gesù, probabilmente la sua compagna. Si dice anche che il campanile della basilica di San Felice fu il primo della cristianità. Un'altra leggenda vuole che San Gennaro fosse stato imprigionato ed arso in una fornace, ancora presente.
Leggende o meno, questo è un luogo di straordinario valore storico culturale e di indiscusso fascino che ha attirato, e continua ad attirare, coloro che sono in cerca del “sacro”, in una accezione meno legata alla appartenenza religiosa e più mistica.
© Giovanni Rossi Filangieri 6/2015
Notizie storiche e tecniche: Pro Loco Cimitile